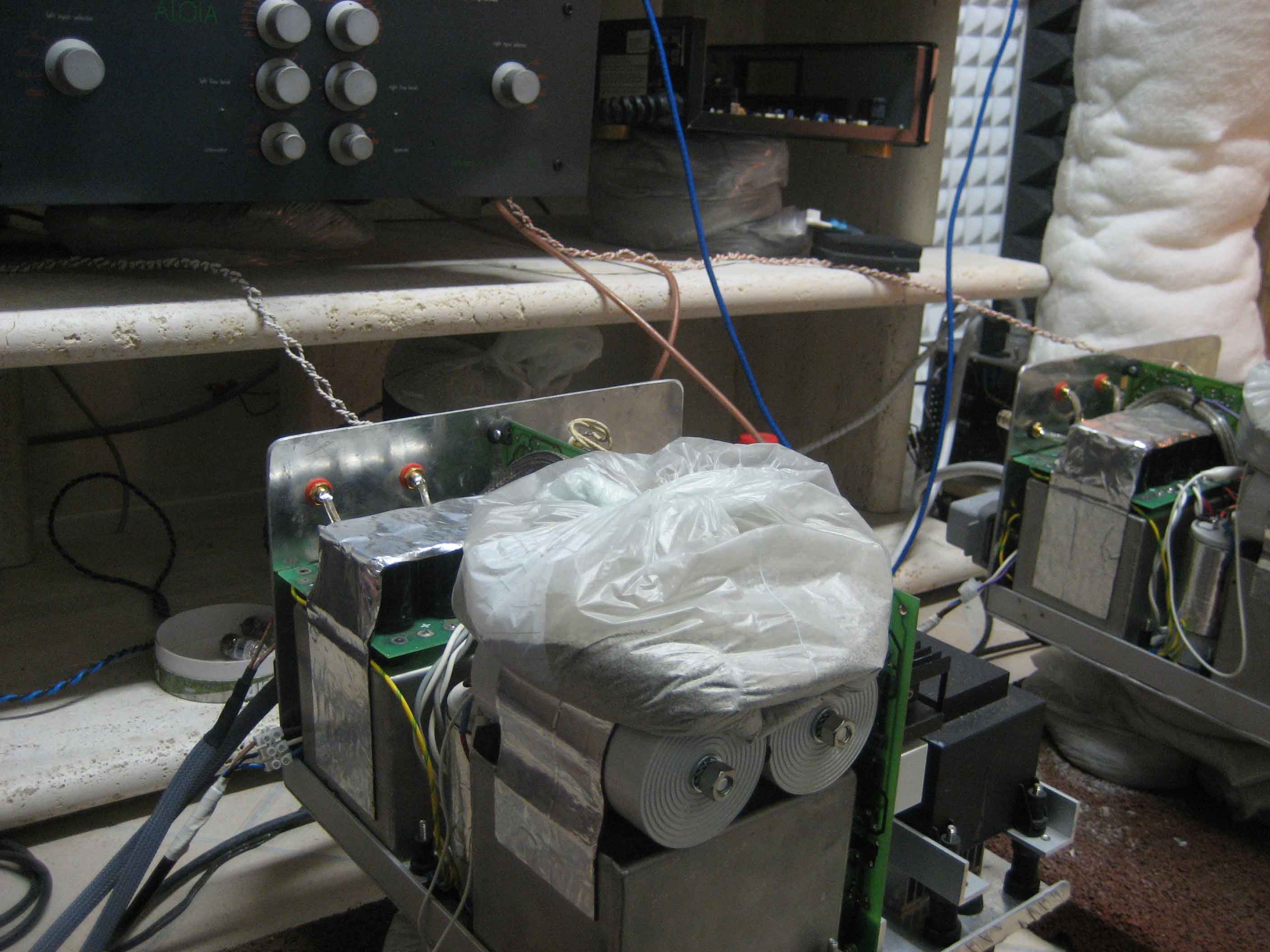"Ben rivisti" tutti quanti.

A me pare che abbiate scritto "molto" o "abbastanza" (data l'osticità del thread) in questi due/tre giorni (di week end peraltro!), e mi fa piacere, perché mi fa pensare che forse c'è un interesse, a prescindere da chi si espone volontariamente al pubblico ludibrio.
Personalmente sono molto contento che Valerio Russo non abbia abbandonato la questione, che Mauro Penasa abbia voglia di parlarne nonostante tutto, sono molto contento degli interventi di plo' e riccardo, e sono molto confuso sul "a chi" e/o sul "che cosa" potrei/dovrei/vorrei provare a rispondere (anche appunto per via dei davvero tanti interventi che si sono succeduti, rispondendosi a vicenda).
Al momento ho due dubbi principali (non direttamente connessi a mr. x): che cosa sia il cd. metodo scientifico, che cosa indaghino gli attuali setup di misura.
Io comincio dal primo aspetto, perché sono ignorante nel secondo (e mi piacerebbe imparare da Mauro e Valerio) e perché mi sembra propedeutico a tutta una serie di incomprensioni, prima di tutto tra una "vecchia" scienza certa ed una "nuova" supposta tale (che per me molti, appunto, scusatemi il calembour, è solo una tale supposta...).
Mi pare siano espressioni sufficientemente d'accatto (e quindi in linea con il mio personaggio d'incappucciato un po' goliardico) che la scienza non è la (non si esaurisce con la sola) elettroacustica nota, così come la trasformata di fourier non è uno "strumento" proprio e solo dell'elettroacustica nota (e basta), e nemmeno l'unico, inteso come l'unico sempre dirimente: senza voler (scherzando) arrivare ad un modo di definire "la scienza", non sono certo in grado di fare un'introduzione all'epistemologia come intesa contemporaneamente, mi piacerebbe porre un'ipotesi, concorrente alla definizione di scienza, che peraltro mi pare pacificamente assunta da molti, probabilmente tutti i presenti.
Da Galileo (che faceva gli oroscopi per campare) in poi, storicamente si assume che tra ciò che caratterizzi una disciplina scientifica vi deve essere l'applicazione del cd. metodo sperimentale o scientifico tout court.
Poiché, come dice qualcuno, sono incline alle supercazz*le, e come non dargli torto, vorrei iniziare per il sollazzo vostro (se devo rendermi ridicolo, facciamolo fino a dove mi è possibile) a portare una definizione di metodo scientifico (o sperimentale) e poi, se vorrete farlo con me, riportarvi le rispettive asserzioni.
Il criterio per stabilire se un’ipotesi sia accettabile dal punto di vista scientifico è che, non essendo possibile dimostrare che una QUALSIASI ipotesi sia vera (perché richiederebbe una serie infinita di verifiche), si deve dunque poter dimostrare che sia falsa.
Quindi, per prima cosa, si dovrebbe procedere alla messa a punto di un apparato sperimentale che cerchi di falsificare le ipotesi.
Detto diversamente dell'ipotesi falsificabile, essa deve essere decidibile in base all'apparato sperimentale: insisto su questa cosa per molti probabilmente banale (al punto da darla sempre per presupposta), l’ipotesi sottoposta a verifica sperimentale è decidibile, nel senso della falsificazione, se può essere sottoposta a prova solo da tentativi sistematici per coglierla in fallo (quindi dovrebbesi stabilire cosa indagare, come e quale correlazione ha il fatto indagato con l'ipotesi da falsificare).
Bene, se io affermassi come ipotesi falsificabile che (ad es.) in una qualsiasi reazione chimica la "massa" si conserva sempre, al momento sono ragionevolmente sicuro che, se trovo una reazione in cui non si conserva, l’ipotesi è da scartare (e sono ragionevolmente sicuro che Mauro Baudino potrebbe trovarmi un esperimento, semplice, magari da fare in casa, per confutare tale sciocca ipotesi).
Dunque, l'ipotesi falsificabile io l'ho espressa in un post precedente ed ora la riporto: l'ipotesi è che il "suono musicale", intendosi con ciò un segnale codificato stereo inciso su un supporto contenente un brano di musica, non sia rispetto all'uomo (al suo cervello inteso come apparato rivelatore/elaboratore) un semplice aggregato di armonici, ma una sequenza ordinata nel tempo di suoni ciascuno con un proprio cd. "tempo di esistenza", comprensivo di attacco, durata, decadimento. Ora, se non vogliamo chiamarlo "tempo di esistenza" (o "suono musicale") poco importa, usate termini diversi o più usuali, l'ipotesi (salvo smentite o precisazioni) dovrebbe restare esattamente identica a se stessa, e cioè, la specifico diversamente per completezza, che i suoni musicali siano descritti dai tempi di esistenza dei suoni che contengono e dai loro rapporti reciproci *rispetto* al cervello umano (e non ad un microfono!).
L'obbiezione di Valerio Russo (sparsa in qualche post) che qua qualcuno fa le ipotesi ed a noi resterebbe verificarle (e che ciò non sia giusto, e che dovrebbe "darci" da pensare), o viceversa di Mauro Penasa che qui qualcuno lascia a qualcun'altro il lavoro sporco, nulla aggiungono e nulla tolgono (secondo me) ad uno scenario in cui, per cultura, ci si potrebbe proporre di indagare tale ipotesi falsificabile.
Al momento ad un tale (eventuale, ipotetico) proporre io ho ricevuto risposte varie, ma che a me sono "suonate" più o meno riconducibili - per tenore, non per le singole argomentazioni - alle seguenti: "lascia perdere, siamo *noi* la vera scienza" - "non farti prendere da un entusiasmo mal riposto", "è l'arroganza ad intimorirti al punto di farti affermare cose che non comprendi" - "è qualcun'altro che deve dirti cosa afferma" - e simili.
Tutte posizioni lecite, espresse da persone verso le quali (nei limiti in cui possa valere un'esperienza di forum) io nutro viva simpatia e stima (almeno per le qualità umane espresse nelle relazioni!), tuttavia nessuna di esse, per me, assomiglia ad una confutazione dell'ipotesi dal punto di vista del metodo scientifico (o sperimentale). Ed io, francamente, sto per arrendermi: resterò dunque somaro?

Parrebbe quasi quasi di si: come si dice, chi vuole Cristo se lo preghi (e purtroppo non ho la vocazione per farmi prete, di qualsivoglia religione).
--- --- ---
Ciao, Luca